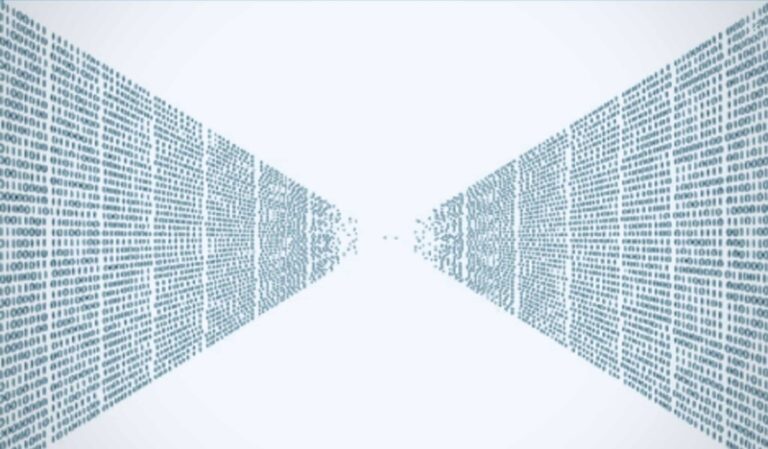
Trentaquattresima puntata del nostro viaggio
Abbiamo iniziato a riflettere nel precedente post sulla necessità di una seria azione politica per governare la trasformazione digitale, analizzando il settore delle infrastrutture, il problema della gestione dei dati e il caso della formazione. La riprendiamo e concludiamo con questo post, che è anche l’ultimo della serie: ne approfitto quindi per ringraziare l’Osservatorio sullo Stato Digitale dell’IRPA per l’ospitalità, invitando chi volesse approfondire i temi trattati in questa “passeggiata” alla lettura del mio volume La rivoluzione informatica.
Nella Pubblica Amministrazione (PA) si continua a sostenere l’importanza della trasformazione digitale, senza però comprendere che generali senza adeguati eserciti non possono nulla. In assenza di un significativo numero di assunzioni di diplomati e laureati in informatica, efficienza ed efficacia della PA non riusciranno a migliorare. E mentre sono sicuro che i “soldati digitali” escono ben formati dalle nostre scuole e università, che preparano diplomati e laureati in informatica che si fanno onore dovunque nel mondo, ho qualche dubbio che la pubblica dirigenza sia generalmente in grado di capire l’importanza e le implicazioni di usare l’informatica nelle organizzazioni. In molti, troppi, ministeri ed enti pubblici si è rimasti fermi a una visione dell’informatica come meccanizzazione “a silos” di singole funzioni di elaborazione dati, slegate da una visione globale e di processo delle relazioni tra l’organizzazione in sé, le sue interfacce nella rete della PA e i cittadini. Il tutto complicato da una visione tradizionale dell’automazione, secondo la quale una volta che l’esecuzione di una funzione sia stata affidata a una macchina, il problema si possa considerare risolto. Nel caso dell’informatica non è così, la vera informatizzazione dei servizi è sempre in fase di manutenzione (si veda il post Come affrontare la trasformazione digitale), perché è la realtà a essere in continua evoluzione. Ma se non si hanno “in casa” le persone in grado di realizzare questa manutenzione, se si deve ricorrere continuamente al fornitore esterno, costi e tempi lievitano in modo intollerabile.
Nel settore privato abbiamo ancora una carenza culturale, discussa qui, che ha sinora frenato il sistema produttivo. Ma c’è anche un’altra importante considerazione. Il nostro tessuto industriale è costituito in maggioranza da micro e mini imprese, che hanno fatto di creatività, flessibilità e velocità la chiave per arrivare, da paese sconfitto e distrutto dopo la seconda guerra mondiale a settima potenza industriale al mondo. Queste non usano tecnologie digitali o le usano poco non perché – come dice qualcuno – sono pervase dal “familismo amorale” o non ne hanno capito il potenziale di vantaggio competitivo, ma perché sistemi informatici troppo rigidi costituirebbero la melassa che li ucciderebbe rapidamente.
Il tipico industriale italiano – per niente stupido e che della flessibilità e velocità di cambiamento ha fatto la sua arma strategica – l’ha intuito e ne è stato alla larga: primum vivere! Ha capito che l’unica informatica buona è quella “personalizzata” che accompagna l’azienda in modo flessibile, come se fosse una persona, ma che è in grado di lavorare senza stancarsi e senza sbagliare, come purtroppo accade alle persone. E questo non si può ottenere semplicemente comprando soluzioni “chiavi in mano”, come è avvenuto per le precedenti innovazioni tecnologiche, ma si ottiene soltanto se si hanno a disposizione i tecnici in grado di sviluppare tali personalizzazioni man mano che si presenta la necessità. Mentre gli imprenditori sono sempre stati agili nel modernizzare le linee produttive ogni qualvolta hanno intravisto un’opportunità di mercato, nel caso dell’automazione digitale sono prudentemente rimasti alla finestra, capendo il pericolo della sua rigidità che rischiava di far loro sprecare risorse economiche.
Il problema quindi non è solo della cultura delle imprese, ma anche della visione della politica. Erogare finanziamenti pubblici per la trasformazione digitale delle imprese può essere una misura positiva, ma se poi si concretizza nel comprare soprattutto macchinari e soluzioni estere, è difficile che possa contribuire al rilancio del Paese.
Accanto alla definizione di un modello di sviluppo pensato nell’interesse della crescita dell’intero Paese, andrebbe attuato un massiccio programma di supporto alla formazione dei lavoratori attivi, che non può limitarsi alle pur necessarie competenze digitali dell’utente finale ma che dia loro gli strumenti concettuali e culturali necessari affinché il Sistema Italia sia competitivo in quest’ambito.
Tutto questo non dovrebbe essere così difficile da capire, per chi fa politica. E io so benissimo che i politici – contrariamente alla vulgata che li vuole mangiapane a ufo – sono super-impegnati a tutti i livelli, da quello locale a quello nazionale. Temo però che si stia trascurando un po’ troppo un settore che è strategico per il futuro del Paese. Il che non vuol dire lasciar fare ai tecnici. Al contrario, in ogni epoca e paese, chi ha voluto portare i tecnici al governo, presentandoli come sacerdoti dell’imparzialità, ha sempre in realtà voluto sottrarre al popolo (al demos) il potere (il cratos) di controllare l’operato del governo. Si è mosso quindi in modo anti-democratico. La tecnica del digitale non fa eccezione a questo. I sistemi informatici non sono intrinsecamente asettici. La trasformazione digitale non è garanzia assoluta di efficienza ed efficacia. La tecnica deve essere, come sempre, al servizio della politica per implementare questa o quella decisione.
La politica deve decidere come governare questa trasformazione digitale, ben sapendo che cambiamenti epocali di questa portata non si realizzano nei pochi anni di una legislatura e con piani irrealistici. Per questo è necessario un accordo trasversale su un disegno di sviluppo del Paese alla luce della rivoluzione informatica in atto che trovi tutti concordi, per lo meno su alcune linee guida fondamentali. Servono dunque politici che abbiano a cuore la democrazia e il futuro del nostro Paese, che siano in grado di ascoltare cosa la tecnica ha da offrire, di capire quale siano i possibili impatti sociali, e di comporre una sintesi delle esigenze delle diverse classi sociali nell’interesse di tutti.
Serve un’azione strategica di lungo periodo dello Stato, analoga quella svolta nel dopoguerra con l’IRI per ricostruire un tessuto industriale che sostenesse lo sviluppo del paese: è necessario un piano strategico per la “ricostruzione digitale”. Ricordo che l’IRI, con il suo modello di partenariato pubblico-privato, è stato ammirato in Europa come “terza via” per la crescita, tra mercato e nazionalizzazione.
Io sono convinto che, in tutti i partiti, ci siano persone di buona volontà e grande capacità politica. Insieme, possiamo farcela.
( I post di questa serie sono basati sul libro dell’Autore La rivoluzione informatica: conoscenza, consapevolezza e potere nella società digitale, al quale si rimanda per approfondimenti. I lettori interessati al tema possono anche dialogare con l’Autore, su questo blog interdisciplinare, su cui i post vengono ripubblicati a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in questa sede. )