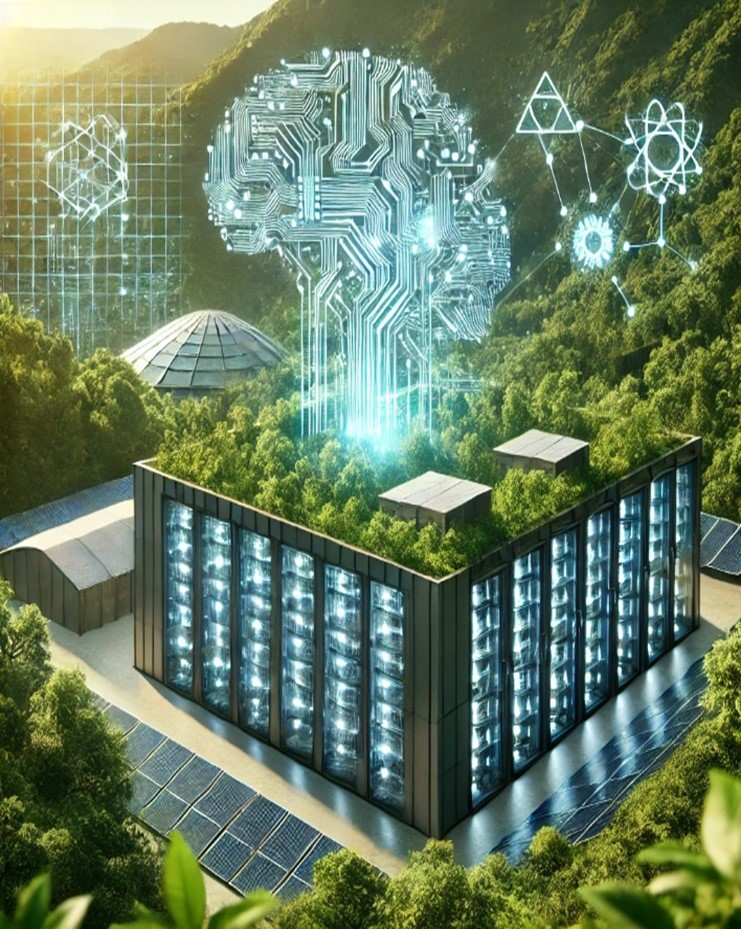
Fonte immagine: ChatGPT
Terza puntata del punto di vista dell’Osservatorio dedicato alla regolazione dei sistemi di intelligenza artificiale tra tutela della riservatezza e tutela dell’ambiente.
Un po’ di conforto; quel minimum consolatorio che basta per poter affermare che l’intelligenza artificiale – nella sua reificazione più assoluta (ossia nelle strutture che fisicamente ospitano gli hardware dell’I.A., i c.d. “datacenters”) e al di là, quindi, del ruolo e della funzione che a essa si suole attribuire, ossia trasformazione e potenziamento delle attività economiche e sociali, miglioramento dei processi decisionali, dell’efficienza operativa e della qualità dei servizi offerti – rechi con sé elementi tali da non compromettere uno dei beni più preziosi del collettivo umano: l’ambiente. Non può negarsi, infatti, come l’asset class dei datacenter sia, oggi, un tema di morboso interesse per gli investimenti immobiliari e ciò in quanto, anzitutto, elementi indispensabili per il consolidamento stesso dell’I.A. L’immediato precipitato dello sviluppo di tali infrastrutture è legato, però, alla loro localizzazione e quindi agli impatti che queste strutture possono recare non solo con riferimento agli spazi urbani, ma anche e soprattutto agli ecosistemi ambientali che l’ordinamento protegge e tutela.
Discutere, giuridicamente, di I.A. e ambiente implica, anzitutto, andare oltre la natura immateriale e virtuale delle tecnologie digitali per proiettarsi nella e sulla “fisicità” delle stesse; tecnologie che, nella loro composizione e per il loro funzionamento, impiegano considerevoli risorse naturali, dato il loro rilevante metabolismo energetico e l’alto tasso di produzione di scarti (quindi, di materiali inquinanti; si pensi, in merito, all’e-waste).
L’impronta ecologica dell’intelligenza artificiale, da tale angolo visuale, è complessa da valutare ma alcuni dati sembrerebbero particolarmente rivelatori: i c.d. datacenter – i cuori pulsanti dell’I.A., ossia quelle strutture che accolgono i sistemi di connessione, i sistemi di storage e i server, il cui scopo è quello di permettere il funzionamento senza soluzione di continuità dei sistemi hardware e software ospitati – rappresentano un’entità significativa di tale tema sotto un duplice profilo, quello del consumo dell’energia (per alimentare dispositivi elettronici come CPU, hard disk, gruppi di continuità ecc.) e quello del consumo dell’acqua (necessaria al raffreddamento dei server che non possono operare ad alte temperature). Invero, un recente report dell’Agenzia internazionale dell’energia stima i consumi di tali infrastrutture tra l’1,3% e il 4,5% della domanda mondiale di energia (dato in crescita così come lo sviluppo dell’I.A.), al netto dei considerevoli sforzi degli operatori del settore per l’efficientamento energetico dei datacenter medesimi, con un Power Usage Effectiveness al ribasso grazie allo sfruttamento delle energie rinnovabili in loco. Non a caso, il profilo dell’efficienza energetica e ambientale di tali infrastrutture già si era posto all’attenzione del dibattito tecnico – in versione light – nel 2021, con riferimento ai datacenter pubblici nel quadro delle strategie nazionali sul cloud (cfr. in particolare, il c.d. “Regolamento AgID sul Cloud della P.A.”, il cui Allegato A individua proprio i requisiti a cui le amministrazioni con datacenter devono adeguarsi).
Più recentemente, ma a livello europeo, il tema – energetico – delle infrastrutture in esame si è riproposto con il Regolamento Delegato (UE) 2024/1774 del 13 marzo 2024, con cui la Commissione ha costituito un nuovo sistema di valutazione della sostenibilità dei datacenter diretto proprio a consentire raffronti tra centri dati e promuovere nuovi assetti o interventi adeguati di efficientamento; ciò al fine di contrastarne l’importante consumo idrico ed energetico. Sul versante nazionale, invece, si rinvengono interessanti spunti prospettici – ancora, però, sul piano dell’energia e non con diretto ancoraggio ai datacenter – nel decreto direttoriale 21007/2024 dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ove, con riferimento alle infrastrutture digitali e dei servizi cloud per la P.A., si prescrivono i livelli minimi tecnici di sicurezza e affidabilità, capacità elaborativa e risparmio energetico del complesso di elementi di cui sopra.
Ma con l’I.A. la questione sembra complicarsi: l’intelligenza di che trattasi, infatti, non solo richiede computer più potenti, ma necessita anche di una maggiore capacità di archiviazione per gestire i dati elaborati. Tanto è confermato dai modelli di deep learning, che vengono addestrati su enormi set di dati che richiedono un notevole spazio di archiviazione e una maggiore potenza di calcolo; circostanze che, ovviamente, si riverberano sulle dimensioni, e quindi sugli impatti ambientali, dei datacenter, in termini sia di consumi energetici che di gestione delle risorse ecosistemiche.
Insomma, il digitale non può dirsi un pasto gratis e certamente non a conseguenze ambientali zero.
L’argomento non è banale e uno spunto curioso (quantomeno ilare), in punto metodologico, ci viene offerto, senza scomodare all’uopo la migliore dottrina, dall’agente segreto di sua maestà James Bond. Ebbene sì, il celebre 007, in uno dei suoi memorabili film, ci racconta la teoria del “quantum di sollievo”, di conforto, che, nel contesto del presente scritto, potremmo così parafrasare: al netto della generale insicurezza del genere umano (che si riverbera pure nella costruzione delle disposizioni di legge che regolano la vita dei consociati, a voler richiamare il celebre sociologo Max Weber), nell’approccio alle “novità” (si pensi all’I.A.) che toccano – o stravolgono – lo status quo dell’ordinamento giuridico, il legislatore tende sempre a prevedere disposizioni, immediate o celate tra una norma e l’altra, che conservino comunque un quantum di sollievo positivo (sottoforma di deroga, di eccezione, di alleggerimento applicativo). Allorché, nell’esecuzione del disposto, la “novità” regolata sfugga dalle maglie predisposte allo scopo, ecco trasformarsi l’originaria – mera – insicurezza giuridica in bieca paura, a quantum di sollievo pari a zero: è qui, a questo punto, che le disposizioni di legge iniziano autonomamente e letteralmente a “scappare” per salvare la pelle, con duplicazioni, sovrapposizioni, abrogazioni a tempo che lasciano l’interprete completamente disarmato.
L’I.A., oggi, sembrerebbe tendenzialmente a quantum positivo (a guardare il Regolamento sull’I.A. quantomeno). Ma la variabile ambientale, nel suo ineludibile magnetismo giuridico, sembrerebbe al momento non essere stata colta, né considerata forse, nella sua intrinseca complessità. Una complessità che potrebbe rischiare di condurre il quantum of solace dell’intelligenza artificiale verso un rischioso livello zero, soprattutto laddove si consideri il tema degli impatti delle infrastrutture necessarie al sostenere la “macchina artificiale” dell’I.A. (i datacenter, al centro dei riflettori della presente nota).
Ebbene, al netto del fatto che, ad oggi, la normativa sull’I.A. non contempla espressamente, né a livello europeo né a livello nazionale, riferimenti alle infrastrutture necessarie per il funzionamento dell’I.A. (per cui – si chiarisce in punto metodologico – i riferimenti ambientali di seguito enucleati pertengono all’intelligenza artificiale “in quanto tale”, ossia in termini di software e hardware), partendo proprio dal Regolamento UE 2024/1689 [sull’A.I. Act, si veda B. Carotti, Punti di vista: l’AI Act; E. Schneider, IA Act e i sistemi di rischio: lungimiranza o nostalgia?], ci si trova, da subito, al cospetto di una affermazione di massima non di poco momento: al considerando 1 (e all’art. 1) si legge infatti che “lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell’Unione, in conformità dei valori dell’Unione, promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente”. Tanto viene rimarcato al considerando 27, ove si chiarisce, sotto il cappello del “benessere sociale e ambientale” che i sistemi di I.A. “sono sviluppati e utilizzati in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente e in modo da apportare benefici a tutti gli esseri umani, monitorando e valutando gli impatti a lungo termine sull’individuo, sulla società e sulla democrazia”. Insomma, l’intelligenza artificiale viene, a ragione, elevata a mezzo “fondamentale” “per la salute e la sicurezza delle persone, per la tutela dell’ambiente e la protezione dai cambiamenti climatici e per la società nel suo insieme” (considerando 130). L’applicazione di questi principi dovrebbe aversi, quando possibile, sin dalla progettazione dei modelli di I.A. e servire da base per l’elaborazione di specifici codici di condotta ossia, ai sensi dell’art. 69 del Regolamento, atti riguardanti l’applicazione volontaria di requisiti specifici a tutti i sistemi di I.A., sulla base di vari obiettivi, tra cui si rinviene, alla lettera b), la riduzione al minimo dell’impatto dei sistemi di intelligenza artificiale sulla sostenibilità ambientale, anche per quanto riguarda la programmazione efficiente dal punto di vista energetico e le tecniche per la progettazione, la formazione e l’uso efficienti dell’intelligenza artificiale.
Ecco, però, manifestarsi la complessità: il Regolamento sull’I.A. reca indicazioni di principio e di massima che confortano, da un punto di vista meramente letterario, ma non convincono da un punto di vista giuridico-applicativo; tant’è che lo stesso Regolamento de quo, nella sostanza, rimette poi la palla, quanto all’effettivo connubio I.A.-ambiente, agli Stati membri (così quantomeno si ricava da una piana lettura del considerando 142: “per garantire che l’IA porti a risultati vantaggiosi sul piano sociale e ambientale, gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere e promuovere la ricerca e lo sviluppo di soluzioni di IA a sostegno di risultati vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale, come le soluzioni basate sull’IA per aumentare l’accessibilità per le persone con disabilità, affrontare le disuguaglianze socioeconomiche o conseguire obiettivi in materia di ambiente, assegnando risorse sufficienti, compresi i finanziamenti pubblici e dell’Unione, e, se del caso e a condizione che siano soddisfatti i criteri di ammissibilità e selezione, prendendo in considerazione soprattutto i progetti che perseguono tali obiettivi”). E tanto si verifica pure con riferimento agli spazi di sperimentazione normativa dell’I.A. (spazi nei quali, a mente dell’art. 59 del Regolamento, “i dati personali legalmente raccolti per altre finalità possono essere trattati unicamente ai fini dello sviluppo, dell’addestramento e delle prove di determinati sistemi di IA nello spazio di sperimentazione” quando sono soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, tra cui, inter alia, “un elevato livello di protezione e di miglioramento della qualità dell’ambiente, la tutela della biodiversità, la protezione contro l’inquinamento, le misure per la transizione verde, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi”) per i quali, al netto di un coordinamento generale da dettarsi a cura della Commissione UE, ampissimi margini sono lasciati alla discrezionalità regolatoria delle autorità nazionali.
Lascia, poi, quantomeno perplessi – con riferimento alla praticità giuridica del profilo in punto di protezione ambientale dai potenziali effetti nocivi dell’I.A. (e delle sue infrastrutture) – l’art. 17 del Regolamento UE in esame ove si prescrive, per i soli produttori di I.A. “ad alto rischio”, un sistema di gestione della qualità che dovrà comprendere, ex aliis, anche quelle procedure relative alla segnalazione di un “incidente grave” (definito, all’art. 3, pt. 49, quale “incidente o malfunzionamento di un sistema di IA che, direttamente o indirettamente, causa una delle seguenti conseguenze: […] d. gravi danni alle cose o all’ambiente”); il profilo non tiene evidentemente conto del fatto che qualunque I.A., nella sua materialità strutturale, può però potenzialmente causare “incidenti gravi”, qui intesi nella prospettiva del grave danno all’ambiente e agli ecosistemi naturali.
Non fa eccezione, sul punto specifico, il d.d.l. nazionale [cfr. M. Cappai, Quale governance nazionale per l’Intelligenza Artificiale?; sia consentito anche il rinvio a G. Delle Cave, Intelligenza artificiale e procedimento amministrativo: friends or foes?] sull’intelligenza artificiale (oggetto, peraltro, di non poche critiche da parte della Commissione UE cit.) all’interno del quale il tema ambientale – che porta con sé lo sviluppo dell’I.A. – è molto diluito, se non del tutto assente. Disposizioni più specifiche e di interesse – nei limiti dell’azione regolatoria propria e dello strumento stesso di soft law – si rinvengono invece nella “Bozza di linee guida per l’adozione di IA nella pubblica amministrazione” dell’AGID rese ai sensi del d.P.C.M. 12 gennaio 2024 (“Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026”), ove, già nei principi generali (art. 5) dello “Schema di Codice Etico e di Comportamento relativo all’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale”, si legge che le previsioni del Codice de quo (volte, in buona sostanza, alla corretta incentivazione e utilizzo dell’I.A. nella P.A.) “si fondano sui valori etici condivisi a livello globale, quali il rispetto e la protezione dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della dignità umana, l’attenzione all’ambiente e agli ecosistemi, la tutela delle diversità e dell’inclusione, nonché la garanzia di vivere in un ambiente pacifico, giusto, basato su un futuro interconnesso a beneficio di tutti”. Segue, più nel dettaglio, l’art. 9, inequivocabile nell’affermare che l’amministrazione (rectius l’“Ente”, ossia, ai sensi dell’art. 1 del Codice, quel soggetto che “adotta il presente Codice Etico di AI e ne agevola e promuove la diffusione”) “valuta e riduce al minimo” l’impatto dei sistemi di I.A. sulla sostenibilità ambientale [comma 1]. La verifica della sostenibilità ambientale, in particolare, delle soluzioni di intelligenza artificiale “può avvenire attraverso il richiamo ai parametri fissati in relazione al principio do not significant harm” [comma 3]. Si legge poi che l’utilizzo delle soluzioni di I.A. “è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile”, così come individuati dall’ONU all’interno dell’Agenda 20230 per lo Sviluppo Sostenibile [comma 2].
Al netto dell’auspicio dell’AGID nella Bozza di linee guide sopra citata (vale a dire, fermi restando gli obblighi di conformità all’A.I. Act, che “le PA DEVONO adottare un codice etico per l’IA. Tale codice DEVE divenire uno strumento di governance vincolante, allineato con il quadro normativo vigente, integrato nei processi decisionali e operativi della PA, finalizzato a un uso responsabile, equo e trasparente dell’IA”, quasi ad auspicare, con fare impositivo, una effettiva implementazione di un sistema di principi e regole tali da facilitare l’ingresso dell’I.A. nei gangli della pubblica amministrazione; cfr. il par. 4.6. “Governance”), è particolarmente interessante, per quanto qui di precipuo interesse: (i) in primo luogo, la previsione di una valutazione – da parte della P.A. – degli impatti dell’I.A. sull’ambiente, al fine non già di contenerli ma di ridurli al minimo; (ii) il richiamo al principio DNSH (non oggetto qui di disamina), che induce a ritenere che la valutazione ambientale supra debba tenere in considerazione la fase di produzione, la fase di uso e quella di fine vita dell’I.A. (e delle sue infrastrutture ossia i datacenter), ovunque si prevedano i maggiori danni.
Proprio quest’ultimo punto, in verità, offre uno spunto di riflessione – per quanto qui di interesse pure de iure condendo – quanto alla possibilità di introdurre una scheda di valutazione ad hoc per la realizzazione dei datacenter proprio al fine di misurare la conformità del singolo intervento infrastrutturale al principio DNSH. Non a caso, infatti, nell’ambito più generale del PNRR, la conformità con il principio de quo viene verificata ex ante per ogni singola misura tramite schede di auto-valutazione standardizzate, che condizionano il disegno degli investimenti e delle riforme e/o qualificano le loro caratteristiche con specifiche indicazioni tese a contenerne il potenziale effetto sugli obiettivi ambientali ad un livello sostenibile). I criteri tecnici riportati nelle autovalutazioni DNSH, opportunamente rafforzati da una puntuale applicazione dei criteri tassonomici di sostenibilità degli investimenti, costituiscono quindi elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione delle misure del PNRR (nel caso di specie, della realizzazione dei data storage funzionali per l’implementazione dell’I.A.). Le Amministrazioni (locali in particolare) sarebbero così chiamate a garantire concretamente che ogni datacenter da realizzarsi non arrechi un danno significativo agli obiettivi di protezione ambientali, adottando specifici requisiti – in tal senso – nei principali atti programmatici e attuativi. Appare evidente che la responsabilità del rispetto del principio verrebbe così affidata non solo alla P.A., che autorizza la realizzazione della struttura in esame, ma anche al soggetto gestore, lungo le varie fasi di attuazione del progettato intervento, ossia ex ante, ma anche in itinere ed ex post in punto di monitoraggio.
Del resto, la centralità del ruolo delle P.A. nella delicatissima fase di tutela ambientale dagli impatti “fisici” dell’intelligenza artificiale (ossia quelli tangibili sul territorio, derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture necessarie per il suo funzionamento) sembrerebbe confermata anche dai primi tentativi di regolare, in qualche maniera, il processo di autorizzazione dei datacenter, attraverso l’adozione di specifiche e puntuali linee guida. Fermo restando il fatto che, ad oggi, per la legge italiana non sembrerebbero esistere i datacenter (salvo, come detto, in pochissimi momenti regolatori), sono emblematiche sul punto la d.G.R. Lombardia 24 giugno 2024, n. XII/2629 – con cui la Regione in esame ha adottato le prime “Linee Guida per la realizzazione di datacenter” – e il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 02 agosto 2024, n. 257 (recante “Linee Guida per le procedure di valutazione ambientale dei datacenter”), entrambi atti aventi quale obiettivo precipuo quello della individuazione delle prescrizioni ambientali e dei criteri di progettazione e pianificazione volti a monitorare e mitigare gli effetti (potenzialmente dannosi) della realizzazione delle infrastrutture de qua. Queste ultime, in particolare, prevedono, inter alia e in conformità con il d.lgs. n. 152/2006, che, per i datacenter con potenza termica nominale dei generatori di emergenza superiore a 50 MW, è necessaria l’autorizzazione integrata ambientale-AIA nonché la preliminare verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale-VIA. Nel caso in cui, invece, la potenza complessiva superi i 150 MW, il progetto deve essere assoggettato tout court al procedimento di VIA. Si prevede, inoltre, che per tutte le istanze relative alle strutture di medie e grandi dimensioni, è necessario verificare, in base a quanto previsto dalla pianificazione comunale, se l’intervento necessiti della procedura di valutazione ambientale strategica-VAS. Al di là delle misure volte alla tutela delle matrici ambientali nel loro complesso, colpisce – in positivo – lo sforzo delle linee guida ministeriali di inserirsi nella complessa questione relativa alla gestione del fine-vita dei server e dei rifiuti elettronici, per i quali si prescrive l’obbligo di presentazione alternativamente di uno studio di impatto ambientale (SIA) o di uno studio preliminare ambientale (SPA), oltre ad un piano di monitoraggio ambientale, che tengano esattamente in considerazione i rifiuti prodotti nel ciclo vita del datacenter e dei relativi effetti sull’ambiente.
Quid iuris in punto di pianificazione dei cuori dell’I.A.? Volendo isolare i punti maggiormente rilevanti ai fini della presente nota, la discrezionalità amministrativa qui, al netto degli strumenti di soft law appena citati, è decisamente preponderante (pure con riferimento alla valutazione dell’impatto sul paesaggio, sulle reti ecologiche ecc.) purché orientata, verrebbe da aggiungere, ai parametri ESG. In punto urbanistico, invero, le linee guida appena citate rimarcano la compatibilità dei datacenter con le destinazioni d’uso produttiva e direzionale; tuttavia, data la strategicità di dette infrastrutture per lo sviluppo e l’implementazione dell’I.A. su più livelli (ivi incluso quello fondamentale dei servizi pubblici), sarebbe lecito aspettarsi la loro inclusione nella più puntuale categoria dei servizi privati di interesse pubblico o generale (con i susseguenti benefici in termini di volumetrie assentibili e agevolazioni in punto di pagamento del contributo di costruzione), con premialità specifiche in relazione a temi urbanistici quali gli standard da cedere e realizzare (cfr., nello specifico, i parcheggi, poco rilevanti – a ben vedere – con riferimento a strutture certamente non ad “alto tasso” occupazionale umano).
Se, quindi, da un lato, la tutela ambientale dall’I.A. pare trovare conforto positivo (“solace”) con riferimento ai profili autorizzativi e localizzativi dei datacenter, dall’altro, maggiori difficoltà e incertezze (in termini di minore sensibilità regolamentare) sembrerebbero rinvenirsi con riferimento alla gestione del ciclo vita delle strutture in esame in termini ampi e con riferimento sia alle fasi pre che post operative (dalla estrazione dei materiali per la realizzazione dell’apparato hardware al fine vita della componentistica elettronica).
Da tale angolo visuale, al fine di poter meglio apprezzare gli impatti di un datacenter (i.e. dalla realizzazione delle componenti base alla fase di utilizzo e cessazione dell’attività), ben potrebbe trovare applicazione la metodologia del Life Cycle Assessment (LCA), che, di fatto, consente di quantificare i carichi energetici e gli impatti ambientali generati durante l’intero ciclo di vita di un qualsiasi prodotto, processo o attività. Non a caso la funzione del LCA è proprio quella di tenere traccia di tutte le interazioni che beni e servizi hanno con l’ambiente lungo il loro ciclo di vita, per poi infine valutare gli impatti direttamente o indirettamente generati, suggerendo altresì possibili azioni di miglioramento: il pregio non è indifferente con riferimento ai datacenter, dal momento che sono considerate tutte le fasi chiave di una determinata filiera produttiva, a prescindere che sia associato a fornitori, clienti, trasporti, smaltimento dei rifiuti o altri processi, rilevando qualsiasi tipo di aspetto critico anche al di fuori dei confini diretti dell’attività esaminata (in linea, peraltro, con il principio DNSH supra citato, a chiusura definitiva della cintura di tutela ambientale intorno alle strutture dell’I.A.). Un’analisi, quindi, che certamente potrebbe incasellare l’I.A. (nella sua materialità) all’interno di un modello produttivo sostenibile, ossia compatibile con la tutela delle risorse naturali e la tutela dell’ambiente, pure in linea con gli auspici di principio dell’A.I. Act.
In conclusione, se si guarda al caso datacenter, il quantum of solace dell’intelligenza artificiale non sembrerebbe, in fin dei conti, così positivo: i costi legati all’inquinamento e all’aumento del consumo energetico connessi alla trasformazione digitale sono certamente significativi; de contrario, non sono immediatamente percepibili – anche in termini di efficienza energetica – i benefici delle politiche digitali orientate alla sostenibilità ambientale. Né aiuta, in termini di mitigazione degli impatti energetici e ambientali delle infrastrutture de qua, la recente assegnazione ai datacenter del codice ATECO 63.11 che, come noto, non rientra tra quelli che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese energivore (i.e. ci si riferisce ai vantaggi riservati alle imprese c.d. “ad alto rischio di delocalizzazione”; categoria nella quale pare arduo collocare il settore oggetto di disamina).
Il bilanciamento tra le suddette due anime digital e green merita, quindi, di essere maggiormente attenzionato dal legislatore nazionale, anche attraverso l’implementazione di quelle metodologie e strumenti già esistenti e operativi (si veda la valutazione e i mezzi operativi tipici del DNSH) volti espressamente alla tutela generale dell’ecosistema ambientale. Occasione, invero, da non perdere laddove si consideri che è, oggi, in corso di esame alla Camera il disegno di legge n. 1928/2024 – oltre al d.d.l. 1259/2025 – avente ad oggetto “delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati”: un momento giuridicamente imperdibile non solo al fine di fissare una cornice normativa chiara e univoca per la realizzazione dei corpi fisici dell’I.A. (da un punto di vista edilizio-urbanistico) ma anche per ponderare, e quindi meglio tutelare, l’interesse ambientale in detti sviluppi di asset class. Tantissimi, in tale ottica, i temi da attenzionare: dalla, auspicata, declinazione del principio DNSH nel settore in oggetto, a un ripensamento del codice ATECO per le imprese in esame; dal potenziamento della rete elettrica nazionale – per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale – al riutilizzo e alla riqualificazione di siti dismessi o in dismissione per la realizzazione di nuovi datacenter e delle infrastrutture energetiche di supporto, anche attraverso incentivi finanziari; ciò, oltre ad un ripensamento generale dei criteri autorizzativi da vagliare in ottica di una maggiore tutela ambientale (si pensi all’utilizzo di soluzioni energetiche pulite, alle sperimentazioni innovative di teleriscaldamento e di raffreddamento, alla riduzione di richieste di acqua, alla valorizzazione di sistemi di accumulo di energia a basso impatto ambientale per rendere i centri in oggetto più sostenibili ed efficienti).
Del resto, a citar Leopardi, ma letto in chiave green, “Sempre caro mi fu quest’ermo colle, e questa siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il [datacenter] esclude”.
Osservatorio sullo Stato Digitale by Irpa is licensed under CC BY-NC-ND 4.0