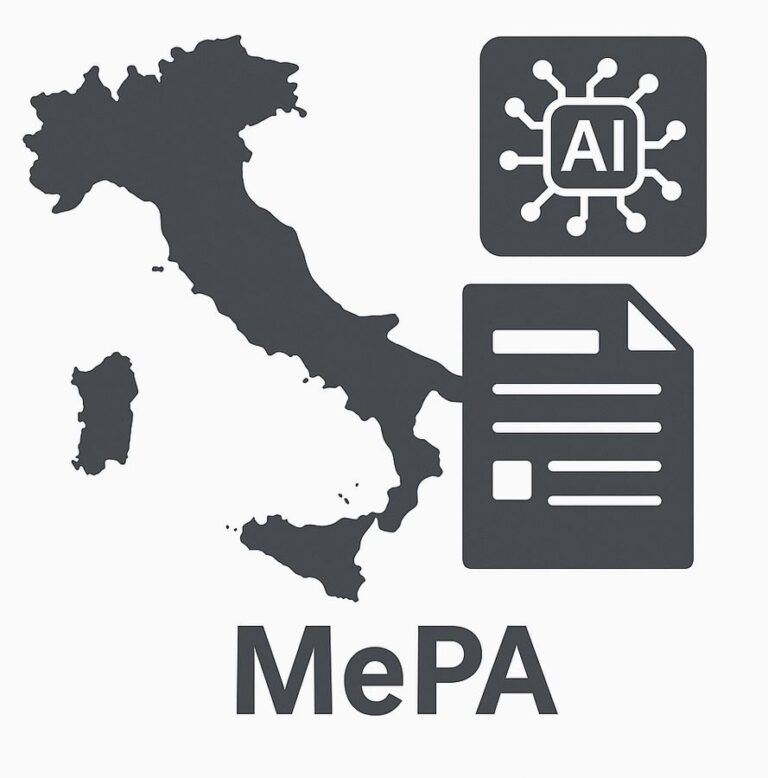
Secondo i dati della Mappa georeferenziata degli acquisti della pubblica amministrazione, messa a disposizione da Consip, il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (il noto MePA) si conferma anche quest’anno come lo strumento di e-procurement più utilizzato in Italia. Con un volume di transazioni che ammonta a diversi miliardi di euro, il MePA costituisce ormai un pilastro nella gestione digitale degli acquisti pubblici sottosoglia eurounitaria, contribuendo all’efficienza degli approvvigionamenti e alla razionalizzazione della spesa pubblica. Tuttavia, a quasi vent’anni dalla sua istituzione, il percorso evolutivo del MePA non può dirsi concluso. Le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) hanno impresso un ulteriore impulso alla sua trasformazione. In quale misura questi interventi hanno effettivamente inciso sulla struttura e sul funzionamento della piattaforma? E quali prospettive si aprono con l’adozione di tecnologie avanzate, come il sistema di monitoraggio basato sull’intelligenza artificiale, noto come MePAwatch? È giunto il momento di fare il punto su ciò che ha funzionato e su ciò che resta ancora da migliorare.
Il MePA, introdotto nei primi anni Duemila con il d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 e gestito da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha rappresentato una delle prime risposte alla crescente esigenza di digitalizzare e ottimizzare i processi di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche italiane. Progettato per semplificare le procedure d’acquisto per importi inferiori alla soglia eurounitaria, il MePA ha progressivamente tentato di ridurre i tempi e i costi amministrativi, incentivando la partecipazione delle piccole e medie imprese e ridefinendo il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e il tessuto economico nazionale. Il MePA si configura, dunque, come un canale privilegiato per la ricerca, il confronto e l’acquisto di beni, servizi e lavori attraverso un ampio catalogo digitale di operatori economici abilitati.
Il percorso evolutivo del MePA non è stato privo di ostacoli. Le aspirazioni di semplificazione e apertura del mercato si sono spesso scontrate con le rigidità burocratiche interne al sistema, che lo stesso MePA avrebbeveng dovuto superare. Interventi normativi, come l’innalzamento della soglia obbligatoria di utilizzo a 5.000 euro per l’acquisto di beni e servizi, stabilito dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio) e operativo a partire dall’anno successivo, hanno cercato di ampliare l’utilizzo della piattaforma, ma non sempre hanno risolto le difficoltà esistenti né superato i limiti strutturali.
Nel 2022, il MePA ha subito un significativo rinnovamento, sia sotto il profilo tecnico che operativo, in linea con le priorità del Pnrr, che ha posto la digitalizzazione dei contratti pubblici al centro delle strategie di modernizzazione (P. Clarizia, Lo Stato Digitale nel PNRR – L’e-procurement, in questo Osservatorio). Le categorie merceologiche sono state riorganizzate, le procedure di abilitazione delle imprese semplificate e l’interfaccia grafica resa più intuitiva, facilitando l’accesso e la registrazione sia per gli operatori economici che per le stazioni appaltanti. Inoltre, l’architettura modulare delle negoziazioni è stata ampliata, articolandosi in quattro livelli di complessità: la trattativa diretta, il confronto di preventivi, la richiesta di offerta semplice e di offerta evoluta, ciascuno progettato per adattarsi alle diverse necessità operative delle amministrazioni. Sebbene la struttura di base dei processi di acquisto e vendita sia rimasta sostanzialmente invariata, queste nuove funzionalità hanno introdotto una maggiore flessibilità nelle procedure, consentendo una gestione più efficiente delle negoziazioni.
Tra le novità introdotte in attuazione del Pnrr, rientra anche il MePAwatch, un sistema di monitoraggio del mercato digitale avviato nel 2021 e destinato a essere completato entro il mese di dicembre 2025. Il MePAwatch si caratterizza per l’integrazione di tecnologie d’intelligenza artificiale, in particolare di machine learning, con tradizionali algoritmi basati su approcci statistici, al fine di analizzare e monitorare i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e degli operatori economici coinvolti nelle transazioni sul MePa. Il principale obiettivo del sistema di monitoraggio consiste nel rilevare eventuali anomalie e prevenire pratiche scorrette, contribuendo così al rafforzamento della trasparenza nelle operazioni di e-procurement e alla prevenzione di fenomeni fraudolenti. Attraverso l’elaborazione dei dati relativi alle transazioni (quali, ad esempio, i tassi di partecipazione alle procedure di gara o i ribassi offerti dagli operatori economici), il MePAwatch si propone di elaborare indici sintetici utili per prevedere comportamenti irregolari e supportare interventi tempestivi, garantendo la correttezza delle procedure di acquisto e il rispetto del principio di concorrenza.
L’aspetto più innovativo del MePAwatch risiede, dunque, nel passaggio da una semplice analisi descrittiva a un’analisi predittiva, che potrebbe migliorare la gestione complessiva del mercato digitale. Accanto alla sua funzione di prevenzione di pratiche scorrette, il MePAwatch si propone altresì di favorire l’identificazione e la diffusione di best practices, incentivando un utilizzo più efficiente e virtuoso del MePa da parte delle pubbliche amministrazioni e degli operatori economici.
Nonostante la Consip abbia dichiarato che sono stati completati alcuni interventi per rendere operativo il MePAwatch – tra cui l’adeguamento dei controlli di back-end e front-end delle funzionalità del sistema e un’analisi dell’impatto sui dati sorgenti, strettamente legata al progetto di rinnovamento della piattaforma di e-procurement e alla relativa transizione del Data Warehouse (Dwh), principale fonte di dati per il MePAwatch – permangono opacità significative riguardo alla configurazione tecnica e alle modalità di funzionamento del sistema. In particolare, come osservato da alcuni (G. Tropea, A. Giannelli, Anticorruzione e regimi di veridificazione. Una traccia, Ceridap) nei documenti ufficiali di Consip non vengono fornite informazioni dettagliate sulla struttura del sistema di monitoraggio, sui processi di analisi e sui soggetti destinatari dei risultati prodotti. Ad esempio, rimane incerta la condivisione dei dati raccolti e delle analisi generate dal MePAwatch con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), responsabile della gestione del casellario, del sistema di rating e del meccanismo di qualificazione delle stazioni appaltanti. Da un lato, l’eventuale trasmissione dei dati all’Anac potrebbe rappresentare un’opportunità per potenziare il coordinamento nella prevenzione della corruzione e migliorare i controlli sull’integrità delle procedure di approvvigionamento pubblico; dall’altro, tuttavia, potrebbe alimentare timori di un controllo eccessivamente pervasivo sugli operatori economici, compromettendo il rapporto di fiducia tra i soggetti coinvolti.
L’attuale scarsa trasparenza del sistema solleva perplessità riguardo all’uso e alla gestione dei dati raccolti e generati dal MePAwatch, il quale dovrebbe essere concepito primariamente come strumento per la lotta alla corruzione, ma la cui governance e gestione operativa rimangono ancora poco chiare.
La recente entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) ha avuto un impatto diretto sul funzionamento del MePA, richiedendo di adattare la piattaforma alle nuove disposizioni codicistiche, che pongono la digitalizzazione al centro del processo di riforma, in linea con il nuovo articolo 19. L’adeguamento del MePA a tali previsioni ha comportato la pubblicazione di nuovi bandi conformi alla normativa del Codice e l’introduzione di obblighi specifici per gli operatori economici abilitati, i quali sono stati chiamati a presentare dichiarazioni aggiornate sui requisiti di partecipazione, come il fatturato globale e i contratti analoghi per le categorie merceologiche di competenza, per continuare a operare sulla piattaforma. L’integrazione del MePA con la Piattaforma Contratti Pubblici (Pcp) costituisce un’altra innovazione, che dovrebbe rendere la gestione degli appalti più coordinata e semplificare il processo di acquisizione del codice identificativo gara (Cig). Inoltre, il sistema di autenticazione per accedere al MePA è stato modificato: non è più possibile utilizzare credenziali tradizionali, ma è obbligatorio l’uso di Spid, Cie o identità digitale europea (eIDAS) per garantire una maggiore sicurezza, in conformità con i nuovi standard di sicurezza definiti dall’AgID.
Nonostante le innovazioni introdotte, sono emersi alcuni problemi nel funzionamento del MePA. In particolare, si registrano difficoltà nel reperimento del Cig di gara e, comunque, tempi eccessivamente lunghi per ottenerlo attraverso la piattaforma. Inoltre, l’accesso tramite identità digitale ha limitato la collegialità del lavoro negli uffici, creando diversi problemi organizzativi, soprattutto all’interno degli enti di minori dimensioni. Come evidenziato di recente dall’Anci, tali innovazioni avrebbero forse richiesto un accompagnamento maggiore, sia attraverso una fase transitoria per testare il nuovo sistema, sia mediante un’adeguata formazione dei soggetti coinvolti.
In definitiva, il MePA ha compiuto significativi passi avanti in termini di digitalizzazione, flessibilità e trasparenza, grazie alle innovazioni introdotte dal Pnrr e a quelle imposte dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, il miglioramento della gestione operativa della piattaforma e l’ottimizzazione del MePAwatch rimangono sfide importanti. Un potenziamento dell’integrazione con altre piattaforme e un uso più avanzato e trasparente dell’intelligenza artificiale, almeno per le analisi statistiche e le funzioni predittive di tendenze e comportamenti del mercato (B. Carotti, Nulla di nuovo sul fronte artificiale: ChatGPT e gli altri, in questo Osservatorio), potrebbero contribuire a rendere il MePA uno strumento ancora più efficace, in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e degli operatori economici.
Osservatorio sullo Stato Digitale by Irpa is licensed under CC BY-NC-ND 4.0